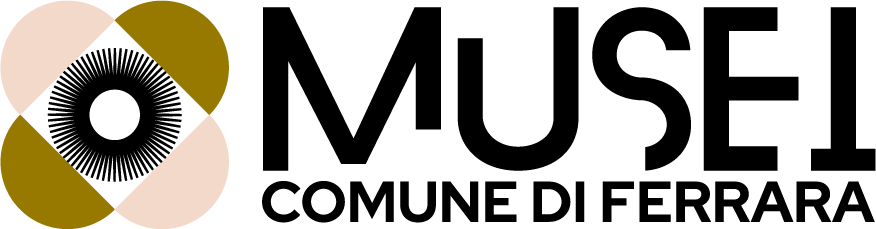Leonor Fini
(Buenos Aires 1907 – Parigi 1996)
La Mémoire infidèle, 1979
Olio su tela, 73 x 100
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis”, inv. 787
Formatasi nel colto ambiente mitteleuropeo di Trieste, frequentato da James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba, Leonor Fini si trasferì nel 1929 a Milano dove entrò nell’orbita di Novecento Italiano promosso da Margherita Sarfatti e divenne allieva di Achille Funi.
Dai primi anni Trenta iniziò a soggiornare a Parigi, frequentando la cerchia degli Italiens de Paris, da Giorgio de Chirico a Filippo de Pisis. Il contatto con Picasso e con esponenti del surrealismo, quali Max Ernst, Salvador Dalí e Paul Eluard, è fondamentale per l’elaborazione di un personalissimo linguaggio pittorico. Nel dopoguerra, dopo una parentesi romana, si stabilì definitivamente nella capitale francese, imponendosi sulla scena artistica e mondana con la sua personalità eccentrica e carismatica. Oltre alla produzione pittorica, animata da visionarie figurazioni di matrice surrealista, si dedicò all’illustrazione, alla scenografia e alla produzione di costumi teatrali, ma amava anche travestirsi con abiti di sua ideazione realizzati da celebri stilisti.
Nel 1983 Palazzo dei Diamanti le dedicò una importante rassegna a seguito della quale l’artista donò due opere del 1979, La Mémoire infidèle e Le crépuscule du matin. Questi dipinti segnano l’evoluzione dell’opera di Fini dai misteriosi impasti cromatici degli anni Cinquanta-Sessanta a una pittura preziosa e levigata che attinge all’universo della storia dell’arte. L’ordine compositivo che regna nella produzione degli anni Settanta veicola comunque significati inquietanti connessi all’universo del ricordo. La Mémoire infidèle inquadra un damerino settecentesco dall’aspetto di manichino che osserva un dipinto appena riconoscibile. Il quadro nel quadro è un’opera reale dell’artista, Le crépuscule du matin, che a sua volta si ispira all’affresco con ninfe dipinto da Bernardo Luini, attorno al 1514, alla villa Pelucca vicino Monza e conservato a Brera. Il ricordo dell’opera rinascimentale studiata in giovinezza acquista però l’accento onirico di una visione notturna. Leonor Fini frappone così in doppio filtro alla propria “memoria”: intende così sottolineare la distanza che ci separa irreparabilmente da ogni più fulgido ricordo e la natura seducente quanto illusoria di ogni forma di rappresentazione.